Donne nella storia: come sono state convinte a tacere
lunedì 14/04/2025
Il 21 marzo Chiara Mercuri ha ricordato come guardare alla storia delle donne sia importante perché permette di individuare i presupposti del patriarcato. Presupposti che quando si verificano hanno sempre portato e potrebbero ancor oggi portare alle stesse conseguenze di discriminazione e repressione nei confronti delle donne.
Prendiamo come esempio quanto accade nell’Europa continentale dopo la disgregazione dell’impero romano e il susseguirsi di invasioni di popolazioni differenti, dove la sopravvivenza e l’insieme delle relazioni sociali vengono affidate quasi esclusivamente alla ‘forza delle armi’. In un contesto di continue razzie per una donna è inevitabile sottomettersi a un uomo in cambio di protezione. La donna che non è di un uomo, prima ancora di diventare bottino di guerra, è donna di tutti, possibile preda anche dei maschi del suo stesso clan. In tempi recenti la stessa cosa è accaduta nei territori dove ha preso potere l’ISIS.
In una società perennemente ‘in armi’ a capo di ogni struttura, a cominciare dalla famiglia, c’è un sempre un maschio che ha potere assoluto su tutti i suoi membri e in particolar modo sulle donne, il cui ruolo è relegato a quello di ‘fattrici’ di futuri guerrieri.
La stessa funzione riproduttiva è sottratta alla potestà delle titolari. Sono gli uomini a stabilire le regole della sessualità, del concepimento, del parto e di ogni altro aspetto attenga al benessere fisico e psichico delle donne. Ancora verso la fine dell’XI secolo, a Salerno, Trotula può esercitare la professione sanitaria e scrivere un trattato di ostetricia e ginecologia (De passionibus mulierum ante in et post partum). A partire dal XII secolo alle donne non è più permesso di fare studi e di occuparsi della salute femminile. Quel poco di sapere che le donne hanno sul loro benessere è tramandato clandestinamente, fuori dei villaggi. Da quel momento scambiarsi ‘i segreti delle donne’ sarà considerato un grave indizio di stregoneria o comunque un comportamento da condannare anche all’interno delle famiglie.
La condanna morale, l’accusa di condotte sessuali non conformi alle regole imposte dagli uomini sono usate contro le donne che provano a far sentire la loro voce. Pensiamo alla lunga damnatio memoriae subita da Eleonora d’Aquitania (1122-1204), attorno alla quale è stata costruita una fama di donna lasciva e immorale. Per rafforzare questa nomea, le viene anche attribuita una relazione carnale con il Saladino che, però all’epoca dei presunti fatti era solo un bambino. Ma a pesare contro di lei è piuttosto l’aver voluto prendere parte attiva alla vita del tempo fino a partecipare alla II Crociata a fianco del marito (Luigi VII Re di Francia).
La cattiva fama di Eleonora d’Aquitania condiziona e oscura l’opera della figlia Maria di Francia(1145-1198). Maria chiede ai più famosi intellettuali dell’epoca di scrivere trattati e romanzi sull’amor cortese. L’amore che ha in mente Maria (essa stessa poeta) non è un sentimento angelicato, poiché in esso trovano piena espressione i sensi, liberi dai vincoli imposti dalla società patriarcale. Il romanzo “Lancillotto. Il cavaliere della carretta” che Maria fa scrivere a Chrétien de Trois, narra un adulterio consumato (soprattutto nella scena finale) che non viene punito né dagli uomini né da Dio. La piena assoluzione dell’amore, anche carnale, tra Lancillotto e Ginevra è dirompente per l’epoca, poiché significa assolvere tutte le donne che – come Eleonora d’Aquitania – osano sfidare le rigide regole del patriarcato. Versioni successive della storia di Lancillotto avranno un altro finale e sull’adulterio peserà la condanna della fine del regno di Camelot.
La storia dimostra che quando a prevalere sono la forza e le armi, le prime a farne le spese sono le donne. La forza del patriarcato si trascina nel tempo e ancor oggi vediamo come la società tenda a far leva sulla reputazione delle donne con frasi del tipo “pensa più alla carriera che ai figli”.
ALLEGATI E LINK CORRELATI



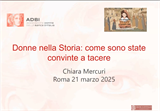

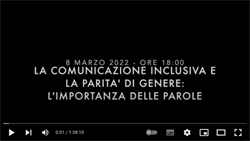

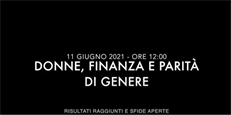




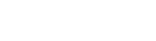
Seguici su